Conosco Mario dai tempi del liceo. Eravamo compagni di classe. Era una persona molto tranquilla, seduto al suo posto anche durante la ricreazione a leggere qualche libro nonostante i quindici anni. Sinceramente non parlavo molto con Mario, preferivo sgattaiolare nei corridoi durante l’ora di latino o fumare una sigaretta in cortile per la ricreazione. Quando abbiamo finito il liceo ognuno ha preso la sua strada e non ho più visto Mario fino a un paio di anni fa. Si era iscritto a matematica, ma aveva una segreta passione per la scrittura. L’ho rincontrato proprio grazie a un racconto che aveva pubblicato su una rivista. La stavano presentando in una libreria ed io ero lì a sorseggiare una birra quando è apparso sul palco a leggere lui, Mario, che teneva il microfono con la mano tremolante e i fogli stampati su un foglio di carta spiegazzato. Ho sbattuto le palpebre più e più volte, incredulo. Ma era proprio lui, quel mio compagno di classe timido e silenzioso che in cinque anni di liceo non aveva neppure imparato dove fosse il bagno? Dunque alla fine aveva trovato il coraggio di uscire fuori dalla sua bolla. Con un sorriso sardonico mi misi in ascolto. Aveva mandato un pezzo a una di quelle riviste underground un po’ punk ma fatte con amore che puoi comprare a 10 euro nelle librerie indipendenti e su cui trovi tanti buoni spunti ma spesso elaborati male. Il suo racconto parlava dell’esperienza interiore di un albero mentre viene segato da un taglialegna. Una storia straziante di dolore e impossibilità di difendersi, mentre anche i canti degli uccellini, che lo avevano allietato per secoli, avevano lasciato il posto al rumore della motosega e dei suoi stessi pezzi, e rami foglie frutti vecchi nudi che collassavano al suolo in un ultimo singulto di coscienza vegetale e vita. Era un brano musicale, più che un testo scritto, sembrava di ascoltare una canzone tristissima, un lamento che con le sue ripetizioni entrava nella tua testa fino al pianto. Una bellezza adamantina e perlacea, viscosa, densa, ritmata, una lanugine di sensibilità che ammorbidiva il mio cuore in modo del tutto inaspettato. Cosa avrei dato io per saper scrivere come lui?
Quando ebbe finito di leggere uno della rivista un po’ punk gli fece alcune domande. Come era nato il racconto, cosa voleva dire con quel racconto, quanto ci aveva messo a scrivere quel racconto. Mario non sapeva bene cosa rispondere. Era impacciato, emozionato, aveva le guance rosse. Balbettò qualche banalità, cincischiando con il colletto della camicia inamidata, un po’ sudaticcio, gli occhi nascosti dietro a degli occhiali da ingegnere. Disse che non lo sapeva, lui non sapeva nulla. Si era messo lì e la cosa era venuta fuori come una lacrima dall’occhio. L’occhio destro, disse senza che nessuno potesse capire il significato di quella precisazione. Disse che per lui scrivere era come piangere: non puoi programmare il pianto, a un certo punto succede, qualcosa lo fa accadere.
Calò un silenzio un po’ imbarazzato e Mario scese dal palco tenendo la testa bassa, impaurito dall’idea di scoprire che il pubblico non avesse apprezzato il suo racconto o che avesse detto qualcosa di sbagliato. Si andò a sedere in un angolo della libreria, strofinandosi le mani per asciugarsele dal sudore. Sul palco salì una ragazza molto spigliata che lesse un racconto pieno di banalità sulla libertà sessuale femminile. Mi feci spazio e raggiunsi Mario, mi misi a sedere accanto a lui.
Ciao Mario, gli dissi toccandogli il ginocchio. Lui mi guardò e sussultò. Ma sei tu? Mi chiese con la bocca aperta. Sono io. Lo abbracciai. Era visibilmente in difficoltà, ma a me non costava nulla fare il primo passo, così gli confessai che avevo trovato il suo racconto bellissimo. Mi sarebbe piaciuto leggerne degli altri. Poi la serata scivolò via e qualche ora dopo ci salutammo con una di quelle vaghe promesse di andarci a prendere un caffè e raccontarci un po’, promesse che rimangono sempre tali. Ci scambiammo i numeri.
Qualche mese più tardi mi arrivò su whatsapp un suo messaggio. Voleva sapere se potevo dirgli cosa pensavo di un racconto che non riusciva a finire. Va bene, gli scrissi, perché non ci andiamo a bere una birra e me lo dai? Lui rilanciò: perché invece non vieni da me, non mi piacciono troppo i luoghi pubblici. Così andai a prendere due birre a un Asia market e suonai il campanello all’indirizzo che mi aveva dato. Mi ritrovai in camera sua, una piccola stanza sudicia e piena di libri ammassati tra loro. Fammelo leggere. Era un racconto sull’esperienza interiore della nuvola nel suo arco di trasformazione dall’acqua che evapora alla pioggia che cade, un prosimetro turchese e grigio e zincato di una elementare perfezione che quando giunsi alla fine provai invidia per quello che riusciva a fare con le parole. Il racconto era per lo più della stessa lunghezza di quello sull’albero, così gli chiesi se avesse mai provato a scrivere qualcosa di più lungo. La domanda lo aveva preso in contropiede, come se ci fosse stato qualcosa di molto sbagliato nello scrivere qualcosa di lungo. I suoi occhi si mossero da destra verso sinistra in modo frenetico e imbarazzato, poi sostenne che tutti i suoi racconti non potevano essere più lunghi o più corti di seimila battute (un sei e tre zeri), spazi inclusi. La sua tecnica di scrittura, confessò, consisteva nello scrivere di getto seimila battute, poi tutte le volte che aggiungeva una battuta doveva assolutamente toglierne un’altra, così che il numero complessivo di battute non cambiasse mai e rimanesse per sempre identico a se stesso. Adesso stava scrivendo il suo terzo racconto. Ci stava lavorando da anni, così che la prima stesura era scomparsa in questo processo di riscrittura che, disse, poteva tendere all’infinito. Anzi, mi confessò abbassando lo sguardo verso terra, i racconti che aveva scritto non erano altro che diverse stesure di quell’unico racconto che stava scrivendo da tutta la vita, sostituzione dopo sostituzione fino alla fine dei suoi temp
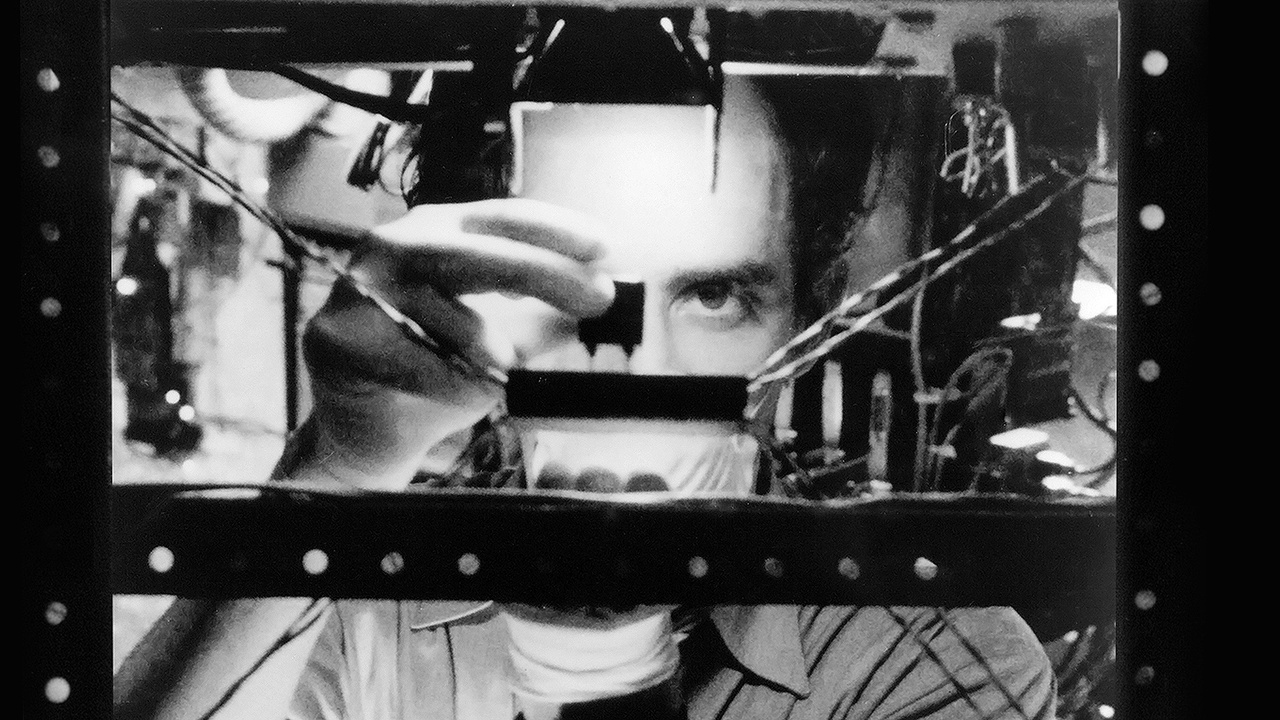
Rispondi